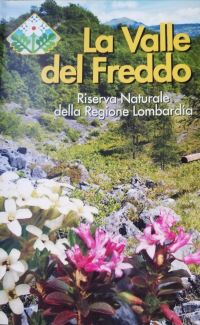In occasione della Giornata Mondiale della Conservazione della Natura (28 luglio) abbiamo optato per una meta a neppure un’ora e mezza d’auto da Milano, il cui nome evoca una situazione molto piacevole in una giornata afosa: si tratta della Riserva Naturale della Regione Lombardia “Valle del freddo”, alla testata della Val Cavallina, ai piedi del Monte Nà (la cui vetta supera di poco i 700 m), nel territorio comunale di Solto Collina (BG). La Riserva, un biotopo/geotopo molto interessante che copre un’area di 70 ettari, è visitabile (gratuitamente) solo in gruppi guidati ed è gestita dalla Comunità dei Laghi Bergamaschi (035/4349811, info@cmlaghi.bg.it, www.cmlaghi.bg.it ): si trova infatti a ridosso del lago d’Iseo, del lago di Gaiano e del lago di Endine, una bellissima zona il cui paesaggio è stato disegnato in particolare dall’ultima glaciazione, la Würm, che coinvolse le Alpi e che si può riferire a un periodo compreso tra i 100.000 e i 10.000 anni fa. Tutti i laghi sono di origine glaciale; la stessa Valle del Freddo ha la caratteristica sezione a U dovuta all’erosione da parte di un ghiacciaio, e vi si trovano testimonianze come massi erratici e detriti morenici.
Il nome “Valle del Freddo” ha sostituito in tempi più recenti l’antico toponimo “Valle del diavolo”, forse più adatto, in realtà, a una situazione effettiva che non rispecchia l’idea di “frescura”: anzi, l’escursione, svolgendosi a bassa quota (circa 300-400 m) per circa un’ora, risente senz’altro delle temperature estive, come abbiamo sperimentato durante la nostra visita nel primo pomeriggio! Il nuovo nome ha comunque un’origine precisa. Risale al 1939 il ritrovamento nella valle, per circostanze fortuite (ben raccontate dalla giovane guida, Ambra, laureata in Scienze naturali e molto preparata), di specie floristiche come la Stella alpina, il Rododendro irsuto, il Raponzolo di Scheuchzer e molte altre, tipiche di quote ben più alte. Gli studi successivi consentirono di scoprire l’associazione di tali insolite presenze botaniche con particolari microclimi, dovuti a “bocche di alitazione” che emettono aria gelida, la cui temperatura è molto più bassa di quella dell’atmosfera circostante (anche 27 °C in meno!). Tali bocche sono aperture tra i detriti rocciosi, di origine glaciale, accumulati nei macereti, sotto i quali la pioggia e la neve cadute s’infiltrano e ghiacciano in inverno; in estate gli strati sovrastanti di ciottoli mantengono piuttosto bassa la temperatura conservando il ghiaccio: l’aria calda che si diffonde dall’esterno verso l’interno di tali strati si raffredda, quindi si appesantisce, scende dall’alto in basso per gravità e finisce per uscire dalle bocche, generando pertanto microambienti freddo-umidi. Durante la visita, che segue un percorso ben delimitato su un sentiero per evitare contaminazioni e danni al prezioso biotopo, abbiamo potuto avvicinare la mano a un paio di tali aperture, cogliendo il soffio gelato che ne usciva. Davvero un fenomeno singolare!
Via via sono state presentate dalla guida le specie botaniche che si incontravano lungo il sentiero: oltre a numerosi ciclamini delle Alpi, all’”aglio delle streghe”, alla silene sassifraga, ecco due esemplari di Stella alpina, specie che normalmente cresce a 1500-2600 m. Frequenti anche i larici, conifere a foglie caduche dei boschi montani. Il paesaggio è reso ancora più complesso dalla presenza della prateria arida, ecosistema caratterizzato da piante macrotermiche; si ritrova frequentemente il ginepro comune.
Dal punto di vista geologico, la zona appartiene alle Prealpi lombarde, ossia ad un settore alpino calcareo le cui rocce ebbero origine, circa 200 milioni di anni fa, dai sedimenti carbonatici dei fondali appartenenti all’antico mare della Tetide. La convergenza continentale tra la placca africana e la placca euroasiatica portò successivamente al sollevamento di porzioni di crosta comprendenti le rocce suddette, ed alla formazione della catena alpina. La roccia in cui è scavata la Valle del Freddo è il calcare di Zorzino, nerastro, impregnato di acido solfidrico derivato dalla decomposizione putrefattiva (in ambiente privo di ossigeno) di organismi marini di acque stagnanti, in bassi fondali. Sfregando tra loro due ciottoli, ecco il caratteristico odore di uova marce!
Anche la fauna presenta notevole interesse: tra i mammiferi sono presenti volpi, faine, cervi, caprioli, lepri, ma non mancano rettili, tra cui la Vipera aspis, e molte specie di uccelli e di insetti. Un sentiero didattico – che può essere percorso liberamente, senza guida – illustra la zona e le tappe più interessanti. La Riserva è una sorta di grande libro aperto di ecologia, in cui si può entrare cogliendo moltissimi spunti di approfondimento e di riflessione. I mesi dedicati alle visite guidate sono attualmente solo maggio, giugno e luglio; è in progetto un potenziamento degli orari di visita, per aumentarne la possibilità di fruizione: appassionati di scienze, amanti della natura, famiglie e semplici curiosi sono quindi avvisati!
Luglio 2024 Anna Busca